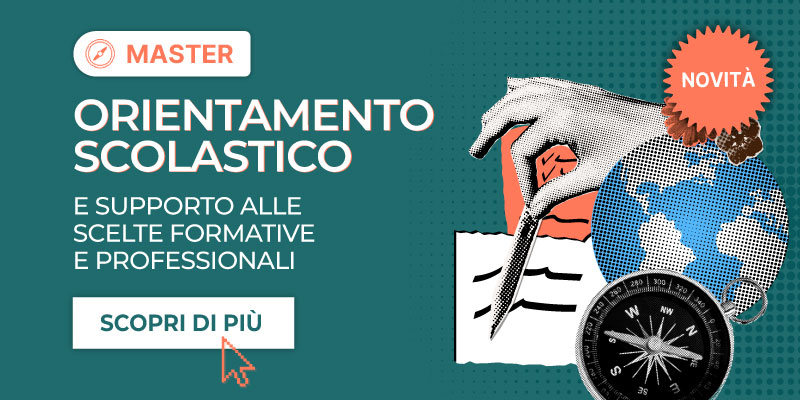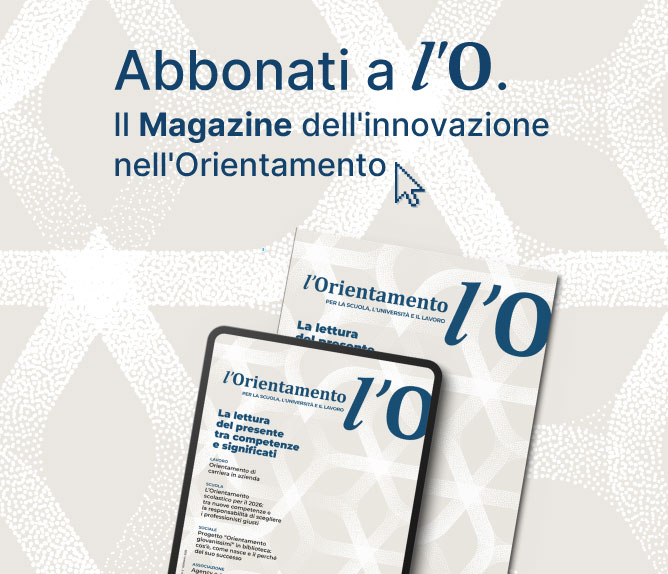- 4770
- 5 minuti
- 9/9/2025
L'Intelligenza Artificiale a Scuola: le nuove linee guida MIM
In attesa della registrazione del Decreto Ministeriale n. 166 del 9 agosto 2025 che ha ricevuto parere favorevole dal Garante della Privacy, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il 29 agosto 2025, ha reso disponibili le Linee guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle istituzioni scolastiche, allegate al provvedimento. A cura di Chiara Sartori, Orientatrice Asnor e Docente.
Secondo il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), l’IA rappresenta una “tecnologia rivoluzionaria” in grado di innovare profondamente la scuola, a patto di metterne al centro il valore pedagogico e i diritti dei soggetti coinvolti.
Le Linee guida sottolineano che l’IA può facilitare la gestione amministrativa e supportare l’attività didattica, ottimizzando processi routinari (come pianificazione del personale o organizzazione dell’orario) e offrendo strumenti didattici flessibili. In pratica, l’obiettivo del Ministero è far sì che le scuole utilizzino l’IA per rafforzare la competitività e la qualità del sistema educativo, senza rinunciare ad un equo accesso e inclusione. Le Linee guida evidenziano infatti che una sua implementazione responsabile può migliorare l’efficienza, promuovere l’inclusione di tutti gli studenti (riducendo le disuguaglianze) e accrescere la qualità dell’offerta formativa.
I quattro pilastri del modello di introduzione all'IA nelle scuole
Il MIM propone un modello di introduzione graduale dell’IA strutturato in quattro pilastri:
- Princìpi di riferimento: linee guida generali che garantiscano un uso dell’IA coerente con i valori scolastici e costituzionali. In particolare, si richiede un approccio antropocentrico (centralità della persona), equo e trasparente, ispirato agli articoli 2 e 3 della Costituzione e alla Carta europea dei diritti.
- Requisiti di base (etici, tecnici e normativi): condizioni minime perché l’IA sia affidabile e sicura. Le Linee guida raccomandano trasparenza (spiegabilità degli algoritmi), intervento umano nei casi decisionali critici e protezione da bias. Sul piano tecnico, i fornitori devono essere certificati (es. ISO/IEC 27001, AgID) e garantire robustezza e sicurezza dei dati. È infine indispensabile la conformità normativa (rispetto del GDPR e dell’AI Act): per esempio, nei casi “ad alto rischio” (come i sistemi che determinano ammissioni o valutazioni degli studenti) vanno effettuate verifiche specifiche e una valutazione d’impatto sui diritti fondamentali.
- Framework operativo: strumenti e fasi metodologiche che accompagnano le scuole passo per passo. Il Ministero mette a disposizione indicazioni per definire un progetto di IA, individuare le aree prioritarie (p.es. didattica personalizzata, amministrazione, supporto all’inclusione) e selezionare i casi d’uso da implementare. Si suggerisce un approccio partecipativo: ogni scuola deve analizzare i propri bisogni, coinvolgere docenti, studenti, famiglie e altri stakeholder nel disegno del progetto, e pianificare attentamente costi, tempi, rischi e obiettivi.
- Comunicazione e governance: azioni per diffondere le linee guida e coordinare gli sforzi fra Ministero e scuole. Il Ministero promuove momenti formativi e tavoli di lavoro con esperti, e ha creato una piattaforma nazionale dove ogni Istituto può accedere ai materiali operativi, alle linee guida interattive e alle esperienze delle altre scuole. In questo modo si garantisce un allineamento continuo fra direttive ministeriali e pratiche scolastiche, con un monitoraggio costante dei progetti IA in corso (anche attraverso dashboard dedicate).
Requisiti etici, tecnici e normativi
Le Linee guida insistono su tre categorie di requisiti:
- Etici: l’IA deve essere impiegata in modo da potenziare, non sostituire, il ruolo umano. In ambito scolastico è fondamentale mantenere sempre un controllo umano sulle decisioni automatizzate, per intercettare tempestivamente eventuali errori o distorsioni. Ogni sistema deve essere comprensibile: le scuole devono conservare la documentazione sui modelli utilizzati e spiegare ai docenti e agli studenti come funzionano gli algoritmi, in modo trasparenti. In questo modo si evitano “allucinazioni” (risultati errati apparentemente validi) e si costruisce fiducia nell’IA.
- Tecnici: i fornitori di sistemi IA devono offrire soluzioni affidabili e sicure. Si consiglia di scegliere prodotti con certificazioni internazionali (es. ISO 27001) e conformi a normative nazionali (es. certificazione AgID per cloud SaaS). Le scuole devono anche accertare che i dati (soprattutto quelli sensibili degli studenti) siano gestiti con adeguate misure di sicurezza (cifratura, back‐up, autenticazione forte). Viene inoltre riconosciuto il diritto di non partecipazione: studenti e famiglie possono decidere di non far usare i propri dati (ad es. nelle conversazioni con chatbots o LLM) a scopi di addestramento, e questa opzione va gestita in modo chiaro senza penalizzare l’accesso alle tecnologie didattiche.
- Normativi: qualsiasi progetto IA a scuola deve rispettare il GDPR e i vincoli del nuovo Regolamento europeo sull’IA (AI Act). In particolare, i dati personali degli studenti vanno trattati secondo i principi di minimizzazione, finalità specifica e privacy by design. I sistemi a rischio medio (ad es. chatbot per le famiglie) devono garantire trasparenza sull’uso dell’IA, mentre quelli ad alto rischio (come gli algoritmi di selezione o vigilanza negli esami) richiedono obblighi supplementari. In quest’ultimo caso, il deployer (la scuola) deve, tra l’altro, eseguire una valutazione d’impatto sui diritti fondamentali (FRIA) e assicurare che il fornitore applichi stringenti controlli su dati e qualità delle procedure.
Opportunità didattiche, di inclusione e di amministrazione dell’IA a Scuola
L’integrazione dell’IA offre numerosi vantaggi per la scuola:
- Didattica personalizzata: l’IA può coadiuvare i docenti nella preparazione di lezioni e materiali didattici differenziati. Ad esempio, il sistema può modulare automaticamente esercizi di vario livello di difficoltà, suggerire risorse aggiuntive su argomenti specifici e creare quiz interattivi. In questo modo ogni studente riceve contenuti su misura per il proprio ritmo e interesse, stimolando curiosità e apprendimento attivo. L’IA può anche generare strumenti innovativi (simulazioni, mappe concettuali, giochi educativi) che rendono le lezioni più coinvolgenti.
- Inclusione: grazie a funzionalità come traduzione automatica e trascrizione live, l’IA rende l’ambiente scolastico più accessibile anche a studenti con bisogni speciali o con difficoltà linguistiche. Sistemi di tutoraggio basati su IA possono supportare gli alunni con difficoltà integrando i loro piani personalizzati, offrendo percorsi di apprendimento alternativi e garantendo che nessuno resti indietro. Anche la partecipazione in classe può migliorare: ad esempio i chatbot educativi stimolano la discussione cooperativa, mantenendo alta la motivazione di tutti i partecipanti.
- Amministrazione scolastica: l’IA alleggerisce i carichi burocratici e ottimizza le risorse. Il dirigente scolastico può usare sistemi intelligenti per monitorare i documenti programmatici (ad es. individuando incongruenze tra Piano Triennale e bilancio). Il personale ATA e DSGA beneficia di chatbot che smistano le richieste più frequenti (iscrizioni, certificazioni, informazioni varie), sistemi automatici per la gestione delle circolari e dell’inventario scolastico. In questo modo si riducono gli errori e si libera tempo prezioso da dedicare all’accoglienza di studenti e famiglie o ad attività educative.
Spunti pratici per un avvio responsabile
L’introduzione dell’intelligenza artificiale a scuola non deve essere vista come un salto improvviso, ma come un percorso graduale, da affrontare con consapevolezza e responsabilità. Alcuni passaggi possono aiutare dirigenti e docenti ad avviare i primi progetti in modo solido e coerente.
Partire dall’analisi dei bisogni. Ogni scuola ha la propria identità e le proprie priorità: per questo è fondamentale chiedersi in quali ambiti l’IA può davvero fare la differenza. Potrebbe trattarsi del supporto alla didattica, della personalizzazione dei percorsi di apprendimento o, ancora, della semplificazione dei processi amministrativi. Una buona bussola in questa fase è il PTOF, che consente di incrociare gli obiettivi educativi con le opportunità offerte dalla tecnologia. È altrettanto importante non lavorare da soli: coinvolgere fin da subito tutte le figure della comunità scolastica – dal dirigente ai docenti, dagli studenti alle famiglie, fino al personale e agli esperti esterni – permette di costruire un progetto partecipato e trasparente. Un gruppo di lavoro interdisciplinare interno, magari in dialogo con università, enti locali o imprese innovative, può diventare il motore di questa trasformazione.
Formarsi e formare. L’IA non è una bacchetta magica: per sfruttarla al meglio occorre conoscerne potenzialità e limiti. Ecco perché la formazione del personale scolastico è un passaggio imprescindibile. I docenti dovrebbero acquisire nuove competenze digitali e sviluppare la capacità di leggere con spirito critico i risultati prodotti dagli algoritmi, senza affidarsi ciecamente a ciò che restituisce la macchina. Allo stesso modo, gli studenti vanno educati a un uso consapevole: saper riconoscere eventuali errori o distorsioni dell’IA significa trasformarla da semplice strumento a occasione di crescita del pensiero critico e della cittadinanza digitale.
Governare e condividere. Per non rischiare di disperdere energie, il Ministero ha messo a disposizione delle scuole una piattaforma digitale che raccoglie materiali, linee guida e buone pratiche. Utilizzarla consente non solo di allinearsi alle direttive nazionali, ma anche di monitorare i progressi del proprio istituto e confrontarsi con le esperienze di altre realtà. Aggiornare periodicamente gli organi collegiali sugli sviluppi dei progetti IA e inserirli nel PTOF rafforza la coerenza del percorso. Inoltre, la collaborazione in rete tra scuole, favorita dagli Uffici Scolastici Regionali, rappresenta un’occasione preziosa per scambiarsi idee e strumenti già testati.
Agire nel rispetto dei valori. Infine, nessun progetto di intelligenza artificiale può prescindere dai principi che guidano la nostra scuola: la centralità della persona, l’equità, la tutela dei diritti. Significa garantire che nessuno resti escluso dall’accesso alle nuove tecnologie, sia per motivi socio-economici che personali, e adottare tutte le misure di protezione dei dati previste dalla normativa europea. Valutazioni d’impatto sulla privacy, regole interne chiare e strumenti di sicurezza sono condizioni imprescindibili per un uso corretto dell’IA. Solo in questo modo la tecnologia potrà diventare davvero un alleato per costruire una scuola più equa, innovativa e capace di affrontare le sfide del futuro.
Conclusioni
Le Linee guida del Ministero sull’IA offrono alle scuole un’occasione importante: non soltanto introdurre strumenti tecnologici innovativi, ma ripensare in chiave nuova l’organizzazione e la didattica. L’intelligenza artificiale, se usata con responsabilità, può alleggerire i carichi burocratici, rendere la didattica più inclusiva e personalizzata, e aprire strade inedite per sviluppare le competenze del futuro.
Al tempo stesso, rimane centrale il ruolo di dirigenti e docenti: l’IA non sostituisce l’educazione, ma la arricchisce, a patto che chi la utilizza sappia governarla, interpretarla e orientarla. La sfida è dunque culturale prima ancora che tecnologica: formare una comunità scolastica capace di adottare l’IA con spirito critico, consapevolezza etica e attenzione alla persona.
Come ricordato nell’AI Act europeo, «i sistemi di intelligenza artificiale nell’istruzione devono promuovere un’istruzione digitale di alta qualità, sostenere lo sviluppo delle competenze e garantire che nessuno studente venga discriminato o escluso». È in questa cornice che la scuola italiana è chiamata a muoversi: coniugando innovazione e valori, per diventare il luogo privilegiato in cui sperimentare un’IA al servizio dell’apprendimento e della cittadinanza democratica.