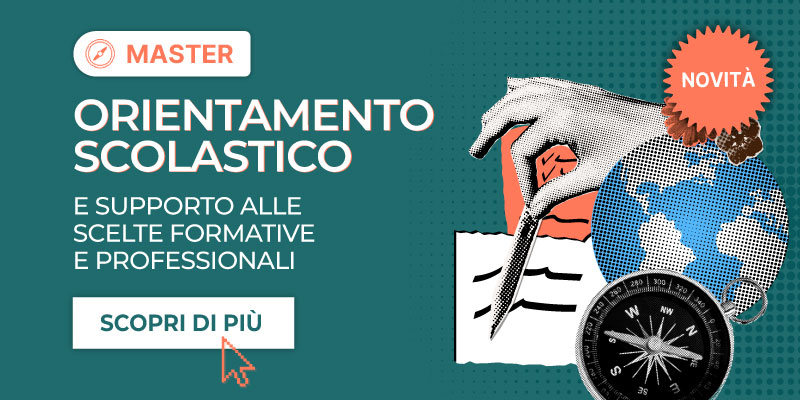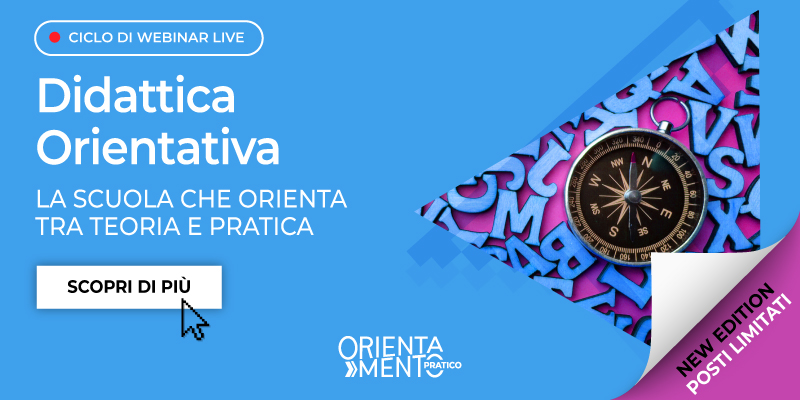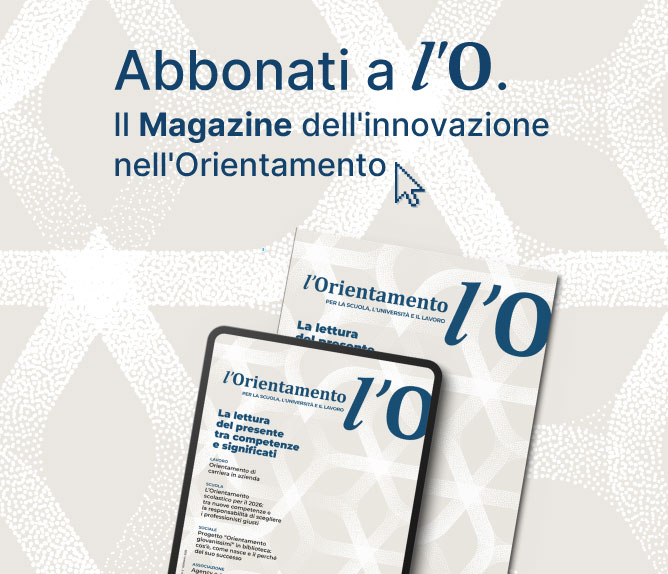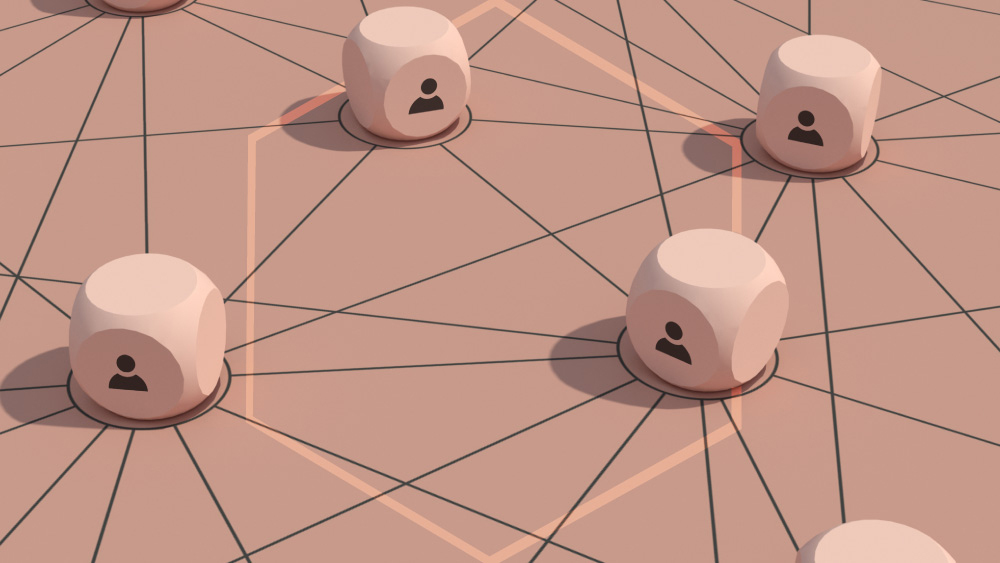
- 1546
- 2 minuti
- 16/10/2025
Il quinto assioma della comunicazione: lezioni di equilibrio tra ruolo e relazione
Riflessioni e implicazioni educative tra ruolo e relazione. A cura di Giorgia Bonadies, Orientatrice Asnor, Formatrice ed Esperta Responsabile dei Processi Formativi (S.I.F. – Scuola Italiana Formatori.
Cos’è il quinto assioma della comunicazione di Watzlawick
Nel corso di quest’anno mi sono trovata due volte – nella veste di formatrice – a confrontarmi con le importanti implicazioni del quinto assioma della comunicazione di Watzlawick, proprio quello su cui (forse perché è l’ultimo in ordine di apparizione) generalmente mi sono soffermata meno. Ed è così che la vita – la migliore delle insegnanti – ha provveduto a farmi recuperare velocemente le occasioni di riflessione precedentemente non colte.
La prima volta, quando mi sono trovata a vestire i panni della formatrice per docenti di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale; la seconda, quando, in prima persona, sono stata io stessa docente presso la sezione minorile dell’Istituto Penitenziario di Catania.
“Tutti gli scambi comunicativi sono simmetrici o complementari.”
Cosa afferma esattamente il quinto assioma della comunicazione di Watzlawick
In quanto assioma, ci descrive molto semplicemente ciò che è nella realtà dei fatti e che pertanto non necessita di dimostrazioni. Fondamentalmente, il quinto assioma ci dice che, nella vita di tutti i giorni, ci relazioniamo in dinamiche di comunicazione simmetrica quando ci troviamo – insieme agli altri soggetti attivi – su un piano di uguaglianza e rispetto reciproco.
Ci troviamo, invece, in dinamiche di comunicazione complementare quando non sussiste, tra i partecipanti, una situazione di uguaglianza, bensì di diseguaglianza, con un partecipante in posizione “superiore” (one-up) e l’altro (o altri) in posizione “inferiore” (one-down).
Quest’ultima condizione si riscontra quotidianamente in molteplici ambiti della nostra vita: in famiglia (tra genitori e figli), sul lavoro (tra un responsabile e un collaboratore) e, nello specifico, in ambito educativo (tra docente e discente). Finché il ruolo di superiorità è riconosciuto dai partecipanti, non si pone alcun problema; ma i nodi vengono al pettine nel momento in cui chi si trova nella posizione subalterna non riconosce – o addirittura disconosce – il ruolo del superiore.
In aula, questa situazione si traduce in mancanza di rispetto e azioni di disturbo da parte del discente, con la conseguente frustrazione, ricaduta emotiva fuori controllo (dalla tristezza alla rabbia) e demotivazione del docente.
Il ruolo
Istituzionalmente, il docente si trova in una situazione di superiorità.
Ma siamo proprio certi che, in quanto essere umano, il discente non stia a sua volta insegnando qualcosa al docente?
Le situazioni di difficoltà gestionale in aula insegnano ogni giorno al docente a crescere in competenze come comunicazione, gestione del conflitto, problem solving, leadership e, più di ogni altra cosa, intelligenza emotiva.
Vivere l’aula nei momenti di criticità significa imparare a riconoscere le proprie emozioni, comprenderne il messaggio e, infine, mettere da parte ciò che è più egoico per ciò che incarna la missione della professione: trovare la chiave di lettura e di azione per aprire la porta del mondo di ogni discente e contribuire al suo percorso di crescita.
In fondo, il docente esiste perché esiste il discente, e entrambi camminano insieme – su un piano spirituale di uguaglianza – in un percorso di crescita senza fine.
La sfida, dunque, è mantenere il ruolo di superiorità gerarchica (un no è un no, una regola è una regola) pur riconoscendo, a livello più introspettivo, il ruolo di parità all’altra parte.
Una sfida che, in realtà, riguarda ogni relazione umana.
La relazione
Non esiste bacchetta magica: si procede per tentativi.
Ciò che conta è costruire relazioni con i discenti su basi “originali”.
Pensando in particolare alle scuole caratterizzate da un alto tasso di abbandono, dove esiste un conflitto culturale con valori differenti, la strada lunga – ma con prospettive di successo – per i docenti è conquistare l’altra parte attraverso la propria leadership carismatica.
Il docente deve riuscire a conquistare prima l’attenzione del discente, ponendosi “vicino” all’alunno – cosa che presuppone grandi capacità di ascolto in assenza di giudizio – per poi affascinarlo, diventando un punto di riferimento, conquistandone la stima e portandolo a riflettere su nuovi punti di vista.
Non esistono regole preconfezionate: ogni singola realtà è a sé.
Conclusioni
Durante il percorso di formazione formatori, ho trovato molto utile proporre un laboratorio di definizione delle “Best Practices” per la gestione dell’aula in situazioni di criticità relazionale. I docenti si sono sentiti motivati, hanno condiviso il proprio bagaglio emotivo, trovato ispirazione e nuova energia. È stato utile anche per me, durante l’incarico presso il carcere minorile.
Perché non dimentichiamolo mai: non si smette mai di crescere e d’imparare, e mentre insegniamo, evolviamo noi stessi. Sempre.