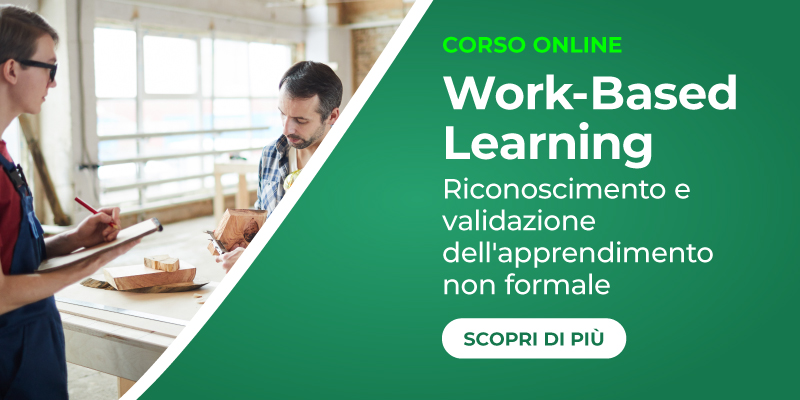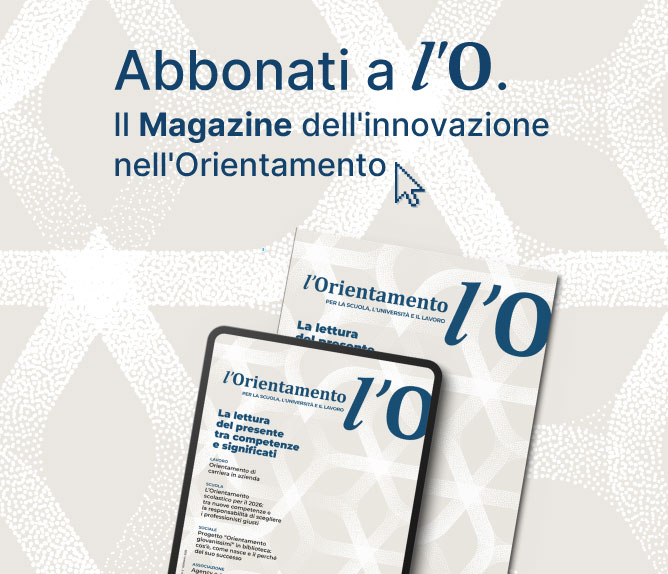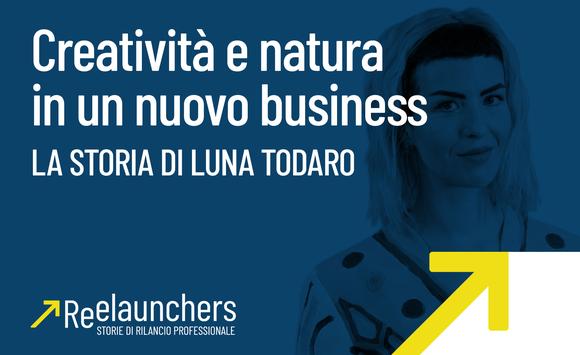- 660
- 4 minuti
- 24/7/2025
LET'S TALK | Puntata 9: Intervista a Maria Cristina Pisani
Una conversazione ricca di spunti interessanti rispetto alla spinta fiduciosa che i giovani italiani hanno, nonostante le tante difficoltà oggettive che vivono in una società gerontocratica come quella italiana.
Puntata 9 – Ospite: Maria Cristina Pisani, Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani, organismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di Politiche giovanili e allo stesso tempo un organo di rappresentanza delle organizzazioni giovanili nazionali. Conduce l’intervista Vito Verrastro, Direttore Responsabile del magazine l’Orientamento.
Ascolta il podcast qui
Oppure guarda la videointervista integrale
VV - Bentornati a Let's Talk, rubrica sulla cultura dell'orientamento ideata e voluta da ASNOR, Associazione Nazionale Orientatori, e dal magazine L'Orientamento, che ho il piacere e l'onore di dirigere. Con noi, oggi, una presenza istituzionale prestigiosa e gradita: quella di Maria Cristina Pisani, Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani, un ruolo istituzionale che ricopre già da diversi anni; per chi non dovesse ancora conoscere il Consiglio Nazionale dei Giovani, vogliamo spiegare cos'è e che cosa fa?
MCP - Il Consiglio Nazionale dei Giovani è un organo istituito da legge, un organo consultivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di Politiche giovanili e allo stesso tempo un organo di rappresentanza delle organizzazioni giovanili nazionali. I Consigli Nazionali dei Giovani infatti sono disciplinati in tutti i Paesi secondo delle raccomandazioni europee, per cui la funzione che noi svolgiamo in Italia rispetto alla attività di consultazione e anche nella definizione delle policies segue gli stessi processi che in modalità leggermente differenti avvengono anche negli altri Paesi dove, a seguito di direttive europee, le politiche giovanili devono essere definite con i Governi attraverso processi di partecipazione diretta dei giovani.
VV - Organo istituzionale che ha un osservatorio particolare, privilegiato sul mondo giovanile. Forse non tutti sanno che, ogni anno, elaborate uno strumento particolare, si chiama Indice di Fiducia, che è chiamato proprio a monitorare l'evoluzione, le aspettative, i sentimenti delle giovani generazioni. Cosa emerge dall'ultimo indice di fiducia che avete elaborato?
MCP - L'indice di fiducia è uno strumento che noi utilizziamo per poter monitorare, attraverso delle fotografie istantanee e immediate, quelli che sono i sentimenti prevalenti delle giovani generazioni. È uno strumento che noi affianchiamo ad un'attività di consultazione diretta delle giovani generazioni, una attività di consultazione che richiede dei processi anche tecnici di rilevazione delle risposte dei giovani molto più strutturata.
L’Indice ci permette di comprendere il sentimento dei giovani a seconda dei momenti, delle fasi storiche rispetto al mondo del lavoro, al contesto sociale, alle pari opportunità. L'ultimo Indice di Fiducia, a chiusura dell'anno 2024, ci ha dato un esito particolarmente significativo che in parte ci permette di comprendere anche qual è lo stato d'animo dei giovani in un contesto - oggettivamente certificato da dati prodotti non soltanto da noi ma anche da altri istituti di ricerca italiani - molto complesso per le giovani generazioni.
Il dato è significativo perché per più del 50% dei giovani c'è un sentimento prevalente di fiducia, di speranza per l'anno 2025. È un sentimento che caratterizza le modalità con le quali le giovani generazioni affrontano le difficoltà oggettive che partono dal mondo della scuola, terminano e proseguono anche oltre l'ingresso nel mercato del lavoro. Noi abbiamo analizzato addirittura le loro prospettive previdenziali, e sono difficoltà che quindi in prospettiva sappiamo e abbiamo raccontato anche attraverso diverse attività di dialogo e confronto; sappiamo che incontreranno oggettivamente, in assenza di strumenti normativi correttivi fino all'età della loro pensione, tutta una serie di difficoltà, a differenza delle generazioni precedenti.
Ed è questo anche il valore di questo dato: nonostante queste difficoltà chiare, hanno un sentimento di fiducia e di speranza, che noi abbiamo letto anche incrociando altri dati che abbiamo analizzato nel corso dell'anno rispetto a questo sentimento prevalente, e che oggettivamente ci dimostra la volontà di essere parte attiva di un processo di cambiamento e quindi non soggetti rassegnati così come molto spesso vengono rappresentati e raccontati.
Ti dò un altro dato, Vito, a dimostrazione di questo sentimento. Anche quando si analizza tecnicamente il numero dei Neet (persone che non lavorano, non studiano e non sono impegnati in percorsi di formazione, ndr), si danno dei numeri statistici, dovremmo interrogarci meglio rispetto ad un acronimo che in realtà rappresenta diverse tipologie di giovani: da chi non studia a chi non cerca opportunità formative o lavorative a chi non lavora; noi abbiamo fatto un'analisi per fotografare e approfondire - perché io lo dico sempre che dietro i numeri ci sono delle vite, che sono calde, in movimento -; sappiamo innanzitutto che il numero dei Neet è molto più basso, proprio perché la rilevazione fredda di chi non lavora, di chi non è in cerca del lavoro, presuppone anche una rilevazione di intenzionalità, colloqui approfonditi con le giovani generazioni, e quindi comprendere anche il perché non si cercano opportunità lavorative. Tu sai che molto spesso, rispetto a questo tema, le giovani generazioni sono state rappresentate come delle generazioni di fannulloni, di persone rinunciatarie... Gli stereotipi sono tanti.
Basta invece leggere e ascoltarli per capirli meglio; per questo l’indice è per noi importante, perché per esempio noi abbiamo scoperto che in realtà, molti di coloro che dichiarano di non cercare lavoro, lavorano in nero. Noi oggi sappiamo che dentro quel numero per cui individuiamo chi non cerca lavoro, chi non vuole riformarsi, chi non lavora o non studia, in realtà ci sono giovani che manifestano un fenomeno ancora più allarmante, che è quello del lavoro in nero. E' un fenomeno allarmante, perché dimostra che c'è un mercato del lavoro complesso rispetto al quale loro cercano degli strumenti di emancipazione a fronte delle difficoltà quotidiane che affrontano.
È centrale il tema della loro emancipazione. Oggi c’è anche il tema della formazione, del lavoro, ma è strettamente connesso ad un tema di emancipazione, per cui si parla anche di casa, di abitazione, di housing sociale, si parla degli strumenti necessari per raggiungere l'obiettivo di rendere i giovani autodeterminanti, capaci di poter definire i loro traguardi, di poter raggiungere i loro obiettivi.
Oggi la maggior parte di loro non riesce per difficoltà oggettive e questo dato ci dimostra che, nonostante queste difficoltà, loro hanno grande voglia e grande capacità di sperare e contribuire ad un futuro migliore.
Lo scorso anno, durante le elezioni europee, abbiamo provato a capire perché il numero dei giovani all'interno delle istituzioni è molto basso, e lo abbiamo fatto con un focus generale su tutte le istituzioni: abbiamo chiesto ai giovani “vorresti contribuire attivamente, partecipando nelle istituzioni, essere parte, credi che i giovani dovrebbero essere più presenti?” L'89% degli under 35 ha risposto “Assolutamente sì”.
La fascia degli under 50, che sono numericamente anche maggiori nel nostro Paese, risponde per il 48% di no, e quando chiediamo la motivazione ci dicono che i giovani sono inesperti. Ora, la legge italiana prevede che a 18 anni si possa votare, stipulare un contratto, guidare un'automobile, sposarsi; perché un giovane è, come dire, al punto di vista giuridico, capace di compiere degli atti, giuridici importanti e non dovrebbe essere capace di rappresentare le proprie generazioni?
A fronte di tanti altri dati, ti potrei parlare degli altissimi livelli anche di istruzione e di formazione che questa generazione ha. Tutto ciò dimostra ancora una volta, a fianco alla percezione del sentimento, un lavoro che abbiamo fatto in profondità e che ci rivela la loro volontà anche di essere parte di un cambiamento.
VV – Grazie per averci portato all'interno di numeri e di scenari che spesso leggiamo in superficie. Il vostro piano programmatico 2023-2025 al primo posto mette la voce “lavoro, formazione e politiche sociali”; in qualche modo sono venute già fuori queste voci nel tuo ragionamento, ma all'interno di questa che si definisce ormai “policrisi” o “permacrisi”, quali sono i fronti su cui occorre lavorare con maggiore urgenza per provare a sistemare alcuni temi tra quelli che hai citato anche tu?
MCP - Innanzitutto lavoro stabile e di qualità. E qui anche c'è la necessità di approfondire i dati. Quando nel corso degli anni lo abbiamo fatto, monitoriamo il tasso di occupazione. Ci sono tantissimi rapporti e diciamo che l'occupazione giovanile cresce oppure cala. Il tema è che poi va visto come cresce e come cala. Ti faccio un esempio: negli ultimi quattro anni i picchi di crescita sono stati picchi di crescita occupazionale, ma non di miglioramento nella qualità del lavoro, perché i redditi sono rimasti gli stessi sostanzialmente, bassissimi - stiamo parlando di 18.000 euro annui lordi, redditi che scendono a 12.000 per il genere femminile -; già dal 2020 noi abbiamo fatto questa analisi: continua a crescere un'occupazione che non è però stabile, perché se vai a vedere la tipologia di nuovi contratti attivati sono tutti contratti atipici.
La percentuale di contratti indeterminati resta molto bassa. E questo che cosa determina? Che in realtà, quando parliamo di occupazione, appunto di crescita dell'occupazione, dobbiamo interrogarci come cresce l'occupazione. Ed è per questo che ti dico “di qualità e stabile”, perché in realtà anche la crescita occupazionale che abbiamo registrato per esempio quest'anno, continua ad essere atipica. E’ un trend che ci portiamo avanti da decenni, questo. La crescita e la decrescita è come se molto spesso le analizzassimo non tenendo conto di questi fattori, che però sono determinanti.
Anche la narrazione del posto fisso non è corretta, perché in realtà oggi il pubblico, rispetto al privato, ha redditi più alti e quindi, rispetto alla scelta di magari svolgere la stessa professione in un mondo privato o in un mondo pubblico, c’è la possibilità di trovare una soluzione leggermente migliore: anche nel pubblico, però, arriviamo a 22-23 mila euro l’anno, lordi. In una città come Roma, un giovane fa fatica a pagare un affitto. E infatti aumentano anche i lavoratori in area di povertà: chi lavora e comunque non ce la fa arrivare a fine mese; guardando anche i dati Istat, ma anche i dati pubblicati dalla Banca d’Italia, la povertà aumenta e per questo tutto va incrociato. Il lavoro che noi facciamo di analisi e proposta è un lavoro che parte dall'ascolto, e quindi l'indice di cui abbiamo parlato, ma anche da un'analisi tecnica approfondita dei dati che poi proviamo a indagare - come vi ho raccontato nel caso di Neet - attraverso analisi che partono dalla rilevazione diretta delle difficoltà, quindi da un ascolto che - che ovviamente vorremmo fare a campioni larghissimi ma poi possiamo fare a campioni ristretti – immaginerai, è complicatissimo, sebbene i giovani sono numericamente pochi nel nostro paese, ma parliamo comunque di milioni.
VV - In base a quello che ci stai dicendo, da un lato abbiamo problemi strutturali, che ci portiamo dietro da una decina d'anni, e dall’altro viviamo in una realtà complessa, perché c'è una bassa produttività, perché ci sono tanti fattori collegati, e quindi veramente è un obiettivo ambizioso quello di avere lavoro di qualità e più stabile, ed è molto difficile in un mondo che diventa sempre più instabile, un mondo in cui le imprese ragionano sempre più su tempi stretti e non su tempi lunghi e anche i giovani, gioco forza, devono fare la stessa cosa.
MCP - Assolutamente sì; permettimi di dire che questo è rispetto alle giovani generazioni, che affrontano delle difficoltà molto tipiche di questa generazione; perché dobbiamo intervenire con mezzi straordinari rispetto alla fascia under 35? Basta guardare le pensioni: chi è entrato dopo l'avvio del sistema puramente contributivo è in difficoltà; se i redditi restano bassi, la precarietà alta, ci sono delle difficoltà oggettive... Il lavoro che noi abbiamo fatto - e di questo ringrazio veramente il Ministro per le Politiche Giovanili, il ministro Abodi - è stato un provvedimento a cui abbiamo lavorato tramite un confronto continuo per quasi due anni: un DL Giovani, proprio per dare un inquadramento alle politiche giovanili, per poter far sì che tutto ciò che accade dal mondo dell'impresa alle politiche sociali, all'orientamento, alla formazione non venissero affrontate in assenza di una legge quadro.
Siamo uno dei pochi paesi che non ha una legge quadro sulle politiche giovanili; un provvedimento che va per leggi di principi, che ci porta ad intervenire in modo coordinato anche ad affrontare dei fenomeni, ad esempio rispetto anche a quello dell'educazione non formale, dello youth work, del riconoscimento di ragazzi che oggi svolgono una professione, ma che tecnicamente nessuno riconosce. Perché non c'è un riconoscimento neppure in un Codice Ateco, perché non esiste, cioè non c'è un riconoscimento dell'educazione non formale. Eppure è un lavoro straordinario. anche per creare coesione sociale. E questo è il tema della interconnessione di cui tu parlavi, che è il tema di cui io sono profondamente convinta quando ti dico occupazione stabile di qualità, perché sono gli elementi base per poter consentire a un giovane di formarsi e quindi proseguire un percorso universitario.
Non tutti hanno la possibilità di avere come ammortizzatore sociale una famiglia, che è quello che per la mia generazione tendenzialmente le famiglie sono state. Un contratto stabile, un reddito, consente di avere un'autonomia abitativa, consente di avere un percorso lavorativo, consente di poter strutturare tutta una serie di appena necessarie per poter raggiungere con autonomia i propri obiettivi.
VV - Ma è ancora possibile questo traguardo del lavoro come c'era fino a 20-30 anni fa? Un lavoro stabile, sicuro, con prospettive, mentre il mondo è cambiato tantissimo, oppure dovremmo provare in qualche modo a incidere sul loro mindset dicendo loro che il mondo sta cambiando e che quindi probabilmente bisogna ragionare un po' anche con paradigmi differenti?
MCP - È una domanda corretta, ti rispondo sì. Qual è il tema per cui io, però, premo molto sul lavoro stabile di qualità? Perché oggi un ragazzo non può neanche scegliere. È un po' il tema che noi per esempio abbiamo affrontato rispetto all'istituzione della Fondo Garanzia per l'acquisto della prima casa. Noi sappiamo che i ragazzi hanno necessità di muoversi: non hanno necessità di avere un posto fisso, una casa fissa, un'abitazione, perché anche a livello europeo il tema è garantire questo diritto ad una stabilità, a chi lo vuole, o ad una flessibilità anche nei percorsi; la voglia di cambiare deve essere una scelta, non una necessità.
È lo stesso claim che utilizzo quando si parla della fuga dell'estero, dei cervelli all'estero, dei giovani. È un dato molto alto, ma anche lì va distinto chi sceglie e chi è costretto: oggi l'Europa è un'opportunità straordinaria per fare un'esperienza all'estero, per acquisire dei valori, delle capacità a proposito di educazione informale e di confronto straordinari.
Il tema è quando diventa una necessità rispetto a cui un ragazzo per trovare occupazione deve necessariamente andare fuori, lontano dai propri cari, dai propri genitori; e per questo ti dico, è correttissimo: io insisto, perché il punto di partenza è la libertà di scelta. La tua domanda è corretta, ma solo nella misura in cui questa flessibilità non diventa precarietà ma scelta, ed è corretta nel momento in cui ci sia un accompagnamento anche rispetto a questa scelta; una scelta che oggi va raccontata ai ragazzi anche rispetto al mondo del lavoro. E lo dico perché noi parliamo sempre del numero dei laureati, cioè qualifichiamo le perdite, ma le perdite non sono solo rispetto ai laureati che vanno all'estero.
Oggi c'è un mondo, quello della formazione professionale, di cui ugualmente si dovrebbe parlare. Oggi esistono dei percorsi lavorativi nuovi, legati all'intelligenza artificiale, legati al digitale. Anzi, ti potrei dire, dalla nostra ricerca, che il disallineamento sul mercato del lavoro oggi, il mismatch, si crea perché noi continuiamo a non orientare i ragazzi, o meglio, a non metterli davanti alla scelta di dire: “Il mercato del lavoro va in questa direzione. Se tu vuoi fare il giurista, il medico, lo puoi fare, però io ti racconto il mercato dove va, ti racconto la professione del medico, come si evolve oggi”; questo non lo facciamo.
Dovremmo riflettere anche sull'alto tasso di abbandono rispetto ai percorsi universitari – ed è un approccio culturale, tipicamente secondo me italiano, non dei paesi nordici sicuramente -: la maggior parte dei ragazzi pensano che l'Università sia una tappa obbligata, mentre abbiamo la necessità di raccontare loro che per trovare un lavoro devono laurearsi non è neanche più vera, perché oggi basta guardare quali sono i trend. C'era un annuncio di una nota, grandissima impresa, rispetto alla quale la figura del manager di area, di una grossa area dell'Europa, veniva richiesta - io lo lessi e mi colpì - tra i requisiti non c’era la laurea e neanche la lingua: c’era la capacità di stare in team, la capacità di problem solving, la capacità di resistenza, ma nel nostro Paese queste queste capacità sono individuate come capacità umane ma non come capacità lavorative. (VV - Invece sono i nostri veri superpoteri al lavoro). Esatto: io ho una capacità di stare in gruppo per l'esperienza che ho fatto, associativa, non perché sono nata con la capacità di essere espansiva, e in questo ritrovo una grande capacità nel saper anche gestire tutta una serie di interlocuzioni: quell'esperienza mi è stata utilissima.
Io sono convinta che c'è un mondo del lavoro, un mondo della formazione che è diverso, che va verso anche obiettivi che ancora non conosciamo - per questo ti parlavo dell'intelligenza artificiale -. Solo che li dobbiamo raccontare, perché i ragazzi abbiano la libertà di sperimentare, di andare, di tornare, ma devono farlo sentendosi liberi. La libertà non è solo quella di scelta, ma è anche quella di poter affrontare dei percorsi di questo modo, con gli strumenti che gli permettano però di essere capaci di poter determinare veramente la loro vita, e non di dover dipendere.
Perché poi il tasso di povertà, soprattutto ad esempio educativa, noi abbiamo scoperto che è ereditario: cioè, di chi non ha una famiglia alle spalle; ecco perché al sud aumenta. Per questo ti dico che c'è la necessità di garantire comunque un assetto di stabilità a loro. Ed è ereditario perché in realtà non c'è in molti contesti un assetto istituzionale pubblico che garantisca, a un ragazzo che viene da un contesto difficile, di poter andare avanti e partire alle stesse condizioni degli altri.
Io ho parlato di una ricerca che a me stupì, perché nel 2024 - ancora oggi - la povertà educativa non è tanto dettata dall'assenza di strutture, ma dal fatto che mancano anche degli strumenti di orientamento pubblici, per cui la maggior parte dell'orientamento avviene attraverso la famiglia e diventa ereditaria, nel momento in cui le famiglie hanno già affrontato difficoltà rispetto a percorsi di formazione, in un mondo che poi cambia.
Ti faccio il mio esempio: mio padre, avvocato, mi racconta la sua professione di 50 anni fa, ma io la vedo a distanza e quindi non riesco neanche a orientarmi, perché oggi la professione è avvocato, ma il processo è telematico. E quindi anche per avere il suo racconto di che cos'è la professione legale, io mi rendo conto che si scontra con la realtà.
Vanno quindi individuati gli strumenti di supporto continuo che permettono ai giovani di essere liberi di poter scegliere cosa fare nella propria vita.
VV - Grazie per la passione con cui sempre sento che affronti questi temi, che ti sono cari non solo per per ruolo istituzionale ma anche proprio per per mission personale, e grazie per aver aperto anche il tema dell'orientamento; qui siamo nella casa degli orientatori; l'Associazione Nazionale Orientatori, ASNOR, è la più importante in italia, quindi ci teniamo moltissimo a raccontare prima di tutto ai professionisti dell'orientamento questi scenari per capire anche con l'aiuto dei nostri ospiti, in questo caso con il tuo aiuto, che ruolo possono avere i professionisti dell'orientamento in questo scenario che stiamo raccontando.
MCP - Posso dirti che è fondamentale, l'orientamento. Io credo che sia la risposta a tutte le domande che tu mi hai posto e a tutti i problemi che io ho avanzato.
Oggi gli orientatori hanno un ruolo straordinario perché permettono, a partire dalla formazione ma anche durante l'ingresso nel mondo del lavoro, di raccontare e supportare i ragazzi in quelli che sono i cambiamenti di cui abbiamo parlato, che sono cambiamenti rapidi, e che quindi permettono anche di poter capire in che modo poter raggiungere i propri obiettivi, in che modo poter veramente affrontare il mismatch tra offerta e domanda, che oggi è lampante. Ci permettono fattivamente, attraverso un supporto diretto, di poter dare un accompagnamento continuo, e non parlo solo della formazione; orientare un ragazzo in una regione del sud o in una regione del centro e una regione del nord significa ascoltarlo, capire cosa vuole fare della propria vita, dove vuole vivere la propria vita e in quel modo, ascoltando le sue esigenze, aiutarlo e accompagnarlo verso i suoi obiettivi lavorativi, personali, professionali.
Oggi gli orientatori hanno un ruolo più grande di quello che immaginiamo. Io non lo leggo soltanto in merito alla formazione o all'ingresso nel mondo del lavoro; lo leggo veramente in relazione ad un orientamento sociale, alla luce di quello che ci siamo detti: di un'interconnessione che deve permettere ai giovani di poter essere liberi - io lo dico sempre - di sognare, di tentare, di poter avere le opportunità, di capire quali sono, cosa accade intorno a loro, e di poter avere tutti gli
stessi strumenti di supporto. Qui è il ruolo dell'orientamento, e per questo io credo molto nell'orientamento già dalle scuole elementari, nonostante si pensi che l'orientamento sia solo verso il lavoro.
Io l'ho visto, nella mia vita, l'ho vissuto: le uniche lezioni di orientamento che mi sono state impartite a scuola sono state al terzo anno di liceo classico, prima di uscire dalle superiori: io mi sono chiesta, ma perché devo fare solo due lezioni?
Mi hanno orientato i miei professori che mi avevano accompagnato per cinque anni. Io, se mi ascolta, lo potrà confermare la mia professoressa di matematica che mi diceva, hai dei voti altissimi, prova un percorso scientifico. Io prendevo ad un liceo classico, che sembrava assurdo, 9-10 in chimica e i miei stessi genitori dicevano, c'è qualcosa che non quadra? E quindi avevo capito già che avevo sbagliato l'orientamento dalle medie al liceo, perché oggettivamente era chiaro che ero molto brava nelle materie scientifiche. E i miei professori, correggendo la scelta di un liceo classico, mi dicevano di provare un percorso scientifico. Ma non era il loro ruolo. Il loro ruolo era quello di orientarmi come professori che mi conoscevano, ma gli orientatori sono figure professionali.
E quando ti parlo di quelle due ore di lezione - per cui io mi sono trovata a sentire “Ma sì, puoi fare medicina, ma anche giurisprudenza, ma anche architettura… “- , dico che invece era necessario un percorso di accompagnamento continuo. Io poi all'università ho fatto altro e mi sono resa conto anche all'università che neanche quello era quello che forse volevo fare; per questo ti dico, l'ho visto sulla mia pelle e per questo ti dico: lo vedo come mio nipote: se avesse dall'inizio, dalle elementari, una persona in grado di supportarti, raccontarti il mondo, coniugare le tue ambizioni, le tue capacità e anche i tuoi interessi, e ti riuscisse ad orientare, sarebbe bellissimo.
Oggi è una figura fondamentale anche per affrontare quel disagio sociale di cui parliamo, rispetto alle giovani generazioni. E che sta diventando una vera e propria emergenza, purtroppo.
Una piaga: perché poi nel momento in cui il disagio diventa anche mancanza di supporto, sfocia nella maggior parte dei casi anche in patologie; ed è la ragione per la quale noi abbiamo provato a lavorare anche sullo psicologo di base, sulla proposta che è ancora oggi in discussione e sulla quale c'è stata grande unità, tanto che è stato presentato un testo unico.
C'è la necessità di supportare, oggi, e di affrontare velocemente un'emergenza che è quella anche di supportare psicologicamente i giovani, ma supportarli dalle patologie più grandi - quelle che vengono definite anche patologie non indicizzate - si può avere un'ansia che anticipi una patologia, così come un panico dettato appunto da una difficoltà lavorativa -. Ci sono diverse tipologie rispetto a cui i giovani devono essere aiutati da figure professionali, quindi da psicologi.
Come lo si fa, in un sistema in cui oggi può farlo solo chi ha la possibilità di accedere al privato? Provando a rendere lo psicologo di base, esattamente come il medico di base, una figura accessibile ad ogni cittadino nei territori. In alcune regioni questo è già stato avviato e sperimentato.
VV - Bene, speriamo che come gli psicologi – che stanno diventando effettivamente professionisti di supporto fondamentali e preziosi - la stessa cosa possa esserci per gli orientatori. Parliamo spesso in ASNOR di orientamento continuo ormai. Ci auguriamo davvero che queste figure possano essere di supporto alle scelte che si sono ormai moltiplicate e che non riguardano solo più i segmenti tra una scuola e l'altra, tra la scuola e il lavoro.
Grazie a Maria Cristina Pisani, grazie al Consiglio Nazionale dei Giovani per l'osservatorio e per lo studio costante, l'ascolto che fa sui giovani italiani, per rispondere alle tantissime sfide che la società moderna e contemporanea ci propone.